Arthur Conan Doyle, baronetto alla corte dello zio Sam, Narrazioni in giallo nero, a cura di Lorella Marinelli ed Elena Ricci, Atti della giornata di studio “Pescara a luci gialle” (2017),
collana Rifrazioni letterarie, Palermo University Press, 2018.
The Sound of the Baskervilles: Sonic Clues to a (Literary) Crime Scene, Studies in Crime Writing, Vol. 1, 2018, Newberry College, South Carolina, USA.

Alessandra Calanchi ritorna sulla scena editoriale holmesiana con due nuovi lavori che guardano al medesimo palcoscenico da due prospettive diverse. Il primo, “Arthur Conan Doyle, baronetto alla corte dello zio Sam”, è al di qua della “quarta parete” che separa la finzione dalla realtà ed esamina la figura di Conan Doyle creatore di Sherlock Holmes e John Watson attraverso una lente a stelle e strisce: l’attenzione si concentra infatti sui legami dello scrittore scozzese con l’America – ovviamente l’America statunitense – sia biografici sia letterari, sia inerenti ai viaggi fisici sia a quelli di fantasia. Calanchi fa giustamente notare come l’unico testo canonico pubblicato esclusivamente per i lettori britannici sia il primogenito Uno studio in rosso, un insuccesso che però conteneva in nuce l’intuizione vincente: l’antefatto americano (ispirato a Il dinamitardo di R.L. Stevenson, per la verità) che, diciamocelo con franchezza, nell’economia della storia poliziesca vera e propria non ha alcun peso, ma che in una lungimirante ottica autoriale costituisce il primo pilastro di un ponte letterario che avrebbe dovuto unire Gran Bretagna e Stati Uniti, due paesi, com’ebbe a dire G.B. Shaw, “divisi da una lingua comune”.
È risaputo che Holmes deve il suo cognome a Oliver Wendell Holmes (1809-1894), medico, poeta e scrittore nativo di Cambridge, sì, ma quella che sta nel Massachusetts. Conan Doyle aveva la consapevolezza precoce, propria degli autori di talento e più moderni, di come la lingua di un britannico, l’inglese, potesse conquistare anche i lettori al di là dell’Atlantico. Gli mancava solo l’occasione giusta per mettere a frutto questa sua consapevolezza, che arrivò il 30 agosto 1889, quando ebbe l’opportunità di cenare assieme a J.M. Stoddart, direttore del Lippincott’s Monthly Magazine, rivista letteraria di Philadelphia aperta a collaborazioni con gli autori d’oltreoceano. La storia è nota: Il segno dei quattro, commissionato a Conan Doyle da Stoddart e pubblicato nell’edizione del febbraio 1890, ebbe un enorme successo e segnò l’inizio di una prima fortunata serie di avventure holmesiane serializzate (e la serializzazione, in epoca vittoriana, era de rigeur) nello Strand Magazine: se in precedenza Conan Doyle aveva scritto strizzando l’occhio a un ipotetico quanto agognato lettore americano, ora scriveva consapevolmente per migliaia e migliaia di lettori reali sparpagliati in tutto il vasto territorio statunitense. La loro dipendenza holmesiana era ormai consolidata, e si diffuse una strana malattia – che è stata definita “American Sherlockitis” – dalla quale erano affetti queste migliaia di lettori degli Stati Uniti e che spinse Christopher Morley, studioso holmesiano cofondatore dei BSI, a teorizzare, con non poca partigianeria, che i signorotti di campagna dai quali Holmes discendeva fossero americani. Il cerchio si chiude se ci aggiungiamo William Gillette (1853-1937), l’Henry Irving d’oltre Atlantico che a partire dall’autunno 1899 portò a teatro il personaggio di Sherlock Holmes, trasportandolo di fatto nella multimedialità (si pensi anche al film muto del 1916 recentemente restaurato), e imponendo addirittura certi oggetti di scena – la famosa pipa calabash – e il fin troppo abusato mantra “Elementare, Watson” mai apparsi nel Canone ma riproposti negli innumerevoli adattamenti cinematografici e nelle tantissime narrazioni apocrife con compiaciuta sfrontatezza.
In merito alla consapevolezza statunitense di Conan Doyle, Calanchi prende anche in esame diversi indizi presenti nelle storie canoniche, soffermandosi in particolare su Il mastino dei Baskerville. Sì, avete capito bene, Il mastino dei Baskerville, la quintessenza di tutto ciò che può sembrare inglese: la brughiera, la nebbia, un antico maniero e un’antica leggenda. Eppure i riferimenti ci sono, sebbene non espliciti come in altre storie, ma velati come il cielo del Devon. Basta saperli leggere. Innanzitutto, suggerisce Calanchi, la brughiera va interpretata come una frontier britannica, dove la natura selvaggia e a volte ostile mette a dura prova uomini e animali (si pensi al povero pony inghiottito dalle sabbie mobili), che, proprio come le famiglie di pionieri americani del West, sono insoliti vicini di casa che vivono a diverse miglia di distanza gli uni dagli altri. La brughiera rappresenta anche l’ignoto dove possono accadere cose terribili, un po’ come accade a Salem, nella Nuova Inghilterra, secondo quanto ci racconta il celebre trattato sulla stregoneria di Cotton Mather, Le meraviglie del mondo invisibile, pubblicato nel 1693, qualche decennio dopo l’epopea tragica della Lettera scarlatta. Sir Henry Baskerville, ultimo rampollo di una schiatta marchiata a fuoco dalle malefatte dell’antenato Sir Hugo, viene dal Nord America (Canada) e degli americani ha – spiacevolmente, si capisce – preso certe abitudini, certe maniere, abbigliamento e modi di dire. Jack Stapleton, alias Vandeleur, alias Rodger Baskerville Jr., chiama wigwams i cerchi di pietra risalenti al Neolitico; i wigwams, in realtà, erano le capanne cerimoniali dei nativi americani: un errore non puramente casuale. Ci sono un tributo a L’uomo della folla di Poe e un riferimento “di parte” a uno dei tanti untold cases del Canone: i delitti Anderson nel North Carolina, tutto ciò in un continuo fraseggio sottotraccia tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Se poi pensiamo che Il mastino dei Baskerville (1901-02) è l’avventura postuma che precede la resurrezione di Holmes e la seconda fortunata serializzazione avvenuta nella rivista statunitense Collier’s Weekly a partire dal settembre 1903, ecco che le suddette tracce a stelle e strisce diventano un succulento antipasto per i lettori crudelmente privati del loro eroe preferito per ben otto anni.
In conclusione, questo baronetto alla corte dello zio Sam afferma da un lato la sua inossidabile britishness – ricordiamo che il titolo di baronetto è ad esclusivo appannaggio di chi è nato suddito del Regno Unito – condita da incrollabile patriottismo, ma al tempo stesso non disdegna d’indossare una seconda nazionalità letteraria per approdare sull’altra sponda dell’Atlantico, in una corte senza monarchi, da tempo rimpiazzati da un burbero vecchietto che sembra uscito da un romanzo di Charles Dickens e che dicono si faccia affettuosamente chiamare zio Sam.

Il secondo lavoro, "The Sound of the Baskervilles", redatto in inglese, è di tutt’altro tenore pur abbracciando tematiche comuni. Se prima eravamo al di qua della “quarta parete”, nel mondo reale, questo breve saggio ci porta al di là di essa, nel reame del Grande Gioco, dove John Watson è l’autore di (quasi) tutte le storie canoniche e Arthur Conan Doyle è soltanto il suo agente letterario. Come già suggerisce il titolo, The Sound of the Baskervilles è una (ri)lettura del celebre Mastino in chiave “soundscape”, ossia “paesaggio sonoro”. Insomma, un paesaggio che, a differenza di quanto accade nei dipinti, non ci arriva attraverso le forme e i colori, ma attraverso i suoni che lo compongono.
Calanchi comincia introducendo i concetti di hearing of the universe, ovvero “l’ascolto (involontario) dell’universo” e clairhearing, parola che fa il verso al vocabolo clairvoyance (chiaroveggenza) e che si potrebbe arditamente tradurre come “chiaroauscultanza”. Cosa bisogna “chiaroauscultare”? La scena del crimine: la nebbiosa brughiera del Dartmoor dove echeggiano i latrati di una creatura soprannaturale, a quanto si crede. Se la chiaroveggenza si definisce come la capacità di “vedere cose non percepibili attraverso i cinque sensi”, la chiaroauscultanza potrebbe essere la capacità di saper ascoltare suoni non percepibili attraverso un udito ordinario allo scopo di localizzarne l’origine e la fonte. Insomma, captare (e interpretare) le emissioni sonore dell’universo che ci circonda (e che non possiamo vedere a occhio nudo) un po’ come fa il grande radiotelescopio di Arecibo, in Cile.
Prima di addentrarsi nell’analisi testuale degli indizi sonori disseminati nel Mastino, Calanchi fa rilevare come l’epoca tardovittoriana e, successivamente, quella edoardiana, siano state caratterizzate da una vasta e variegata produzione sonora, soprattutto urbana: proviamo a immaginare i rumori ai quali erano esposti i londinesi all’epoca delle avventure holmesiane: il clangore delle carrozze, il frastuono dei treni, le grida della folla, il grave lamento dei vaporetti sul Tamigi, persino il suono acuto e stridente dei fischietti che i passanti usavano per chiamare gli hansom cabs, e tanto altro. La campagna, di contro, è un mondo molto più silenzioso, ma non è più quel rifugio ameno di cui ci parla William Wordsworth all’inizio dell’Ottocento. No, la campagna è anch’essa al servizio della città e ne deve subire la chiassosa espansione.
Aggiungiamo ora le invenzioni che fanno rumore o che sono in grado di catturarlo e/o ritrasmetterlo: il motore a scoppio delle prime rumorosissime automobili; il telefono di Meucci (poi usurpato da Bell), capace di portare la voce di una persona all’altra e viceversa senza che esse si trovino nello stesso posto; le prime trasmissioni radiofoniche di Marconi; il fonografo di Edison, poi soppiantato dal grammofono di Berliner, in grado di fissare i suoni e riprodurli. Sono tutte invenzioni che nascono nel già rumoroso fin de siècle e contribuiscono a renderlo ancora più cacofonico di quanto già non fosse. E ora immaginiamoci Holmes, un violinista sopraffino, un musicista dall’orecchio educato e fine, se non “assoluto”, immerso in quella dissonante sinfonia di suoni. Anche la poesia e la letteratura, del resto, registrano, come il fonografo di Edison, i nuovi suoni attraverso neologismi onomatopeici che entrano prepotentemente nel lessico di uso comune.
La campagna dovrebbe dunque essere il regno del silenzio, ma così non è. I latrati del mastino (che poi, diciamocela tutta, è un “hound”, un segugio) rimbombano nella brughiera silenziosa avvolta da nebbie e proprio per questo sono più terrificanti. A Londra, molto probabilmente, non ci avrebbe fatto caso nessuno. A differenza di quanto accade in Silver Blaze, dove il curioso incidente è il cane che non abbaia, nel Mastino l’incidente, non curioso ma spaventevole, è un cane che abbaia da non si sa bene dove, un cane che, soprannaturale o no, è, come tutti i cani, dotato di un udito molto più sviluppato di qualsiasi essere umano ed è quindi in grado di sentire suoni che un essere umano non può sentire; un cane che si può localizzare solo orientandosi attraverso i latrati che emette, amplificati qua e là dal vento, suo alleato acustico; una creatura che non dovrebbe esistere, stando alla ragione, ma che fa cartesianamente pensare ai protagonisti “lo sento, dunque esiste”. Ed è qui che entra il gioco la clairhearing, la capacità di ascoltare e sentire al di là di ciò che si ascolta e si sente normalmente per individuare qualcosa che non si può vedere.
Il soprannaturale, in fondo, perlomeno in quell’epoca, era legato al concetto di sonorità. Ricordiamoci che le séances allora così popolari in Inghilterra, al punto tale che nemmeno Arthur Conan Doyle seppe resistervi, si svolgevano nella quasi totale oscurità, e che lo spirito, prima di materializzarsi sotto forma di una qualche apparizione, si manifestava attraverso una serie di suoni. Un racconto chestertoniano dell’Innocenza di Padre Brown, Il passo strano, pubblicato nel 1911, ci fa inoltre capire come il saper “chiaroauscultare” un suono, un rumore, possa legarsi al concetto di detection: Padre Brown riesce infatti a scoprire il colpevole in virtù del suo “passo strano”, ora lento e misurato, ora veloce e furtivo.
Watson, da cronista coscienzioso qual è, si annota tutte le sfumature sonore che lo circondano e che spesso passano in secondo piano per via dei latrati del terribile molosso. Mortimer sussurra, Sir Charles Baskerville parla con voce tremante, le vittime del cane infernale gridano, i ruscelli mormorano, il vento ulula, le ruote delle carrozze sul terreno accidentato gemono. Il contrasto tra il mortale silenzio che regna a Baskerville Hall e l’ambiente esterno circostante è rimarchevole; proprio per questo i singhiozzi di donna e rintocchi di pendola paiono a un Watson chiuso nella semioscurità della sua stanza come qualcosa di misterioso e indecifrabile. Parafrasando una delle massime di Holmes, si potrebbe concludere dicendo: “Watson, lei ha sentito, ma non ha (chiaro)auscultato”.


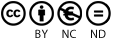










Aggiungi un commento
Fai login per commentare
Login DelosID
